Dopo il lavoro sulla prosa, che nel 2014 ha portato alla publicazione di 16 racconti classici della letteratura europea, ho deciso di rivolgermi alla poesia, ciò che stò facendo tuttora con l’opera di un poeta armeno, Daniel Varujan. In breve, ad un tratto ho aperto il volume dei Meridiani Mondadori contenente l’opera completa di Emily Dickinson, una poetessa americana vissuta fra il 1830 ed il 2886 a Hamerst, una bella cittadina del Massachusset occidentale circondata da prati, boschi e montagne. Un personaggio davvero singolare, che poco a poco si chiuse nella solutudine e il silenzio, tranne qualche uscita, giungendo ad una specie di clausura. Una “monaca” biancovestita che per tutta la vita si confidò con poche persone, soprattutto attraverso lettere e versi, che fù restia a publicare, tranne sètte poesie, tanto che per poco tutto ciò non rimase fù distrutto o perduto. Ma da quel lavoro solitario e nascto uscì (postuma) una raccolta di 1775 poesie che diedero a quella cittadina e al mondo intero una delle più grandi voci poetiche dell’800 e forse di sempre.
La sua opera e la sua storia curiosa, ma fatalmente seria e esemplare, mi hanno profondamente colpito e così, con tutte le difficoltà legate alla mia scara conoscenza dell’inglese e ancor meno del linguaggio della Dickinson, mi sono imbarcato, o meglio tuffato, in un lavoro zeloso e appassionato, scegliendo 100 componimenti, pubblicati sul sito della Chambra d’òc e letti da mio padre. Ma alla fine, preso dal fervore e dalla sensazione di aver trovato la buona strada, ho tradotto più di quattrocento poesie, realizzando quasi una piccola antologia. Perciò, comunque, posso esserne soddisfatto.
La sua lingua chiara e al contempo misteriosa, i suoi versi densi, pieni d’immagini e simboli e il suo ritmo potente, sonoro si prestano bene alla lingua occitana. Una affinità e un legame fra le due lingue che ho scoperto più vicini di quanto pensassi, in ambito filologico (quanto ha preso l’inglese dal latino!), che nella sfera culturale; tanto che, ad un certo punto, la stessa Dickinson parla di “un trovatore sull’olmo” che, in rimando ad un’altra poesia, segna “il cammino”... Identificato con un uccello, naturalmente. E a ben vedere, un trovatore americano, come servirebbe oggi, quanto avrebbe (dopo, chiaramente, aver appreso il blues e un po’ di Jazz) da insegnare al suo popolo! Forse potrebbe comporre un canzone sul “paratge” (lealtà, parità), o anche soltato sulla “convivéncia”, o per dirla con la Dickinson, “l’arte della pace”. Forse!
Se la sua lingua suona vigorosa e moderna, la sua poesia, oltre e fuori dal tempo ben di più di quella trobadorica, pura come la sua candida veste, è un’incessante introspezione e meditazione sui temi più profondi della vita, sulla “battaglia che l’anima cobatte / con nessuno”, dove traspare di continuo la domanda prima sul senso di tutto ciò, se da qualche parte esista qualcosa di perenne, di sacro e se sia raggiungibile dal nostro spirito. Una domanda antica come l’uomo.
Dopo la sua morte fù pubblicata una raccolta di 1775 poesie, un messaggio affidato a mani che, per suo stesso volere, rimasero invisibili alla maggior parte dei suoi contemporanei. Ciò nonostante, il destino ha voluto che nuove mani l’afferrassero e certamente la Dickinson non avrebbe mai immaginato che un giorno quel messaggio sarebbe risuonato in occitano.
96
Sexton! My Master's sleeping here.
Pray lead me to his bed!
I came to build the Bird's nest –
And sow the early seed –
That when the snow creeps slowly
From off his chamber door –
Daisies point the way there –
And the Troubadour.
96
Becchino! Il mio maestro dorme qui.
Ti prego, portami al suo letto!
Sono venuta a costruire il nido dell’uccello,
e a piantare il primo seme.
Sicché quando la neve si disciolga
sull’uscio della sua stanza
le margherite segnino il cammino
insieme al trovatore.


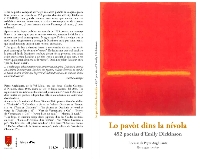
commenta