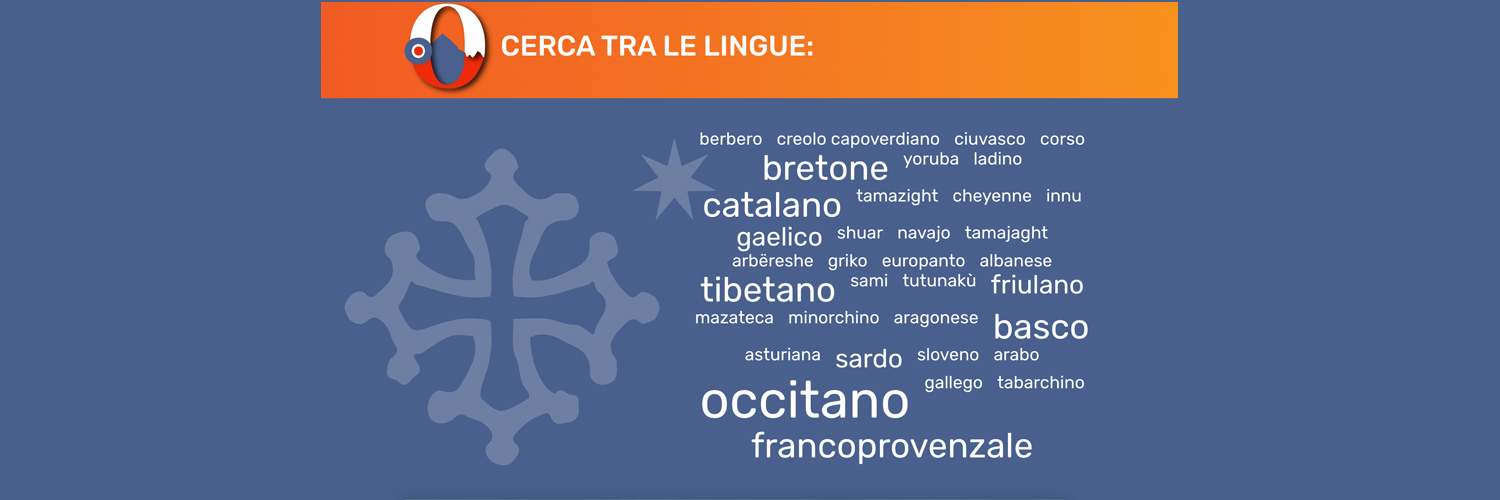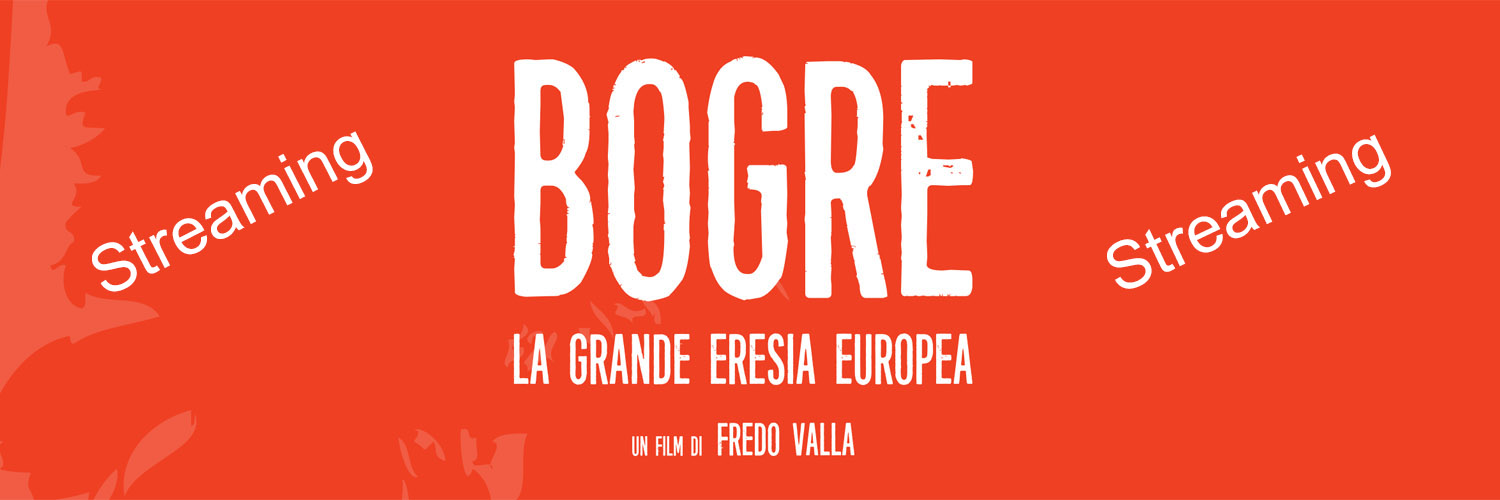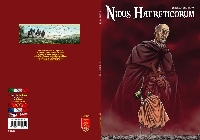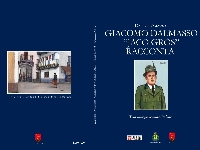Portal d’Occitània
Il portale che raccoglie tutte le informazioni, le notizie, gli eventi e gli strumenti relativi alla lingua e alla cultura occitana
Portal Francoprovensal
Il portale che raccoglie tutte le informazioni, le notizie, gli eventi e gli strumenti relativi alla lingua e alla cultura francoprovenzale
Portal Français
Il portale che raccoglie tutte le informazioni, le notizie, gli eventi e gli strumenti relativi alla lingua e alla cultura francese